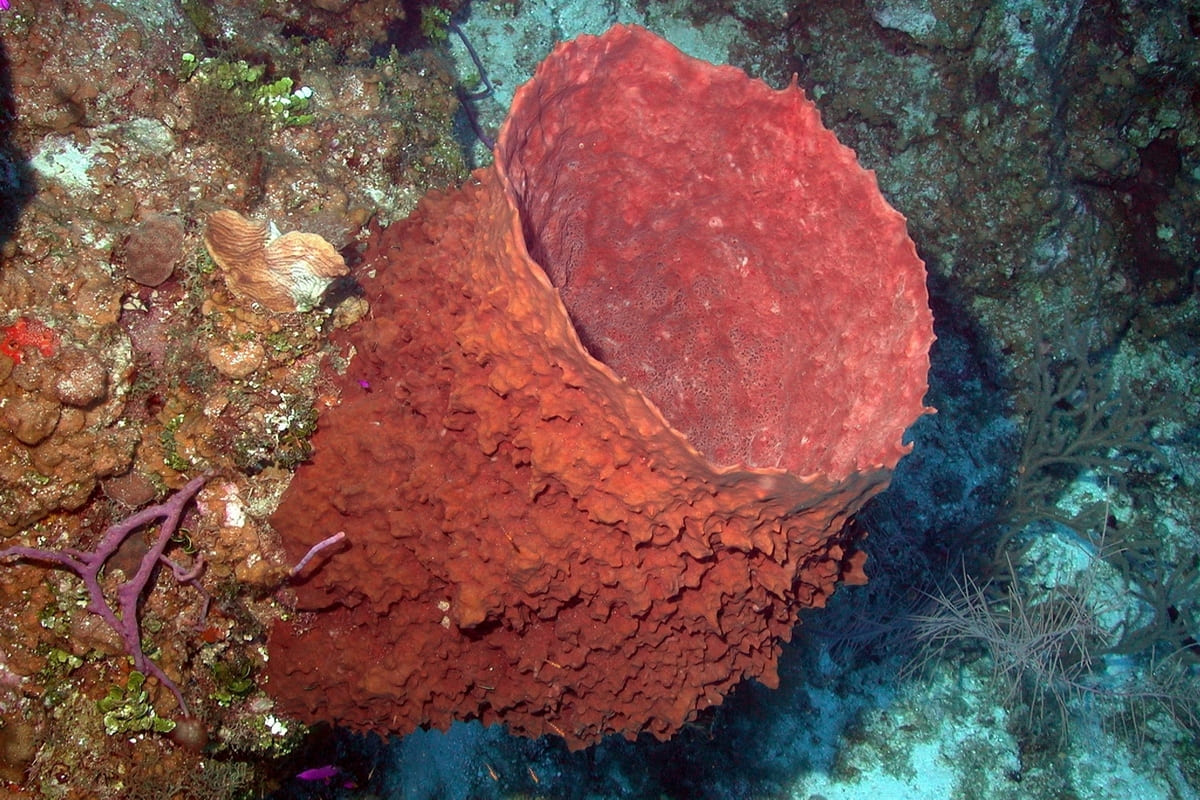Per milioni di anni la natura è stata teatro di una guerra chimica in cui piante, insetti, pesci, anfibi e rettili hanno partecipato a un ciclo continuo di difesa e attacco. Le tossine fungono da arma e da scudo. Alcuni animali non solo hanno sviluppato la capacità di sopravvivere all’esposizione a veleni mortali, ma hanno anche imparato a sfruttarne le proprietà. Lo studio descrive i meccanismi evolutivi alla base della resistenza di alcune specie a sostanze potenzialmente letali. Un esempio significativo è quello di un gruppo di serpenti raccolti nell’Amazzonia colombiana. In un esperimento condotto dalla biologa Valeria Ramirez Castaneda dell’Università della California, Berkeley, questi rettili dovevano scegliere tra nutrirsi o morire di fame. La loro unica fonte di cibo disponibile erano le rane velenose a tre strisce (Ameerega trivittata), la cui pelle contiene istriotoxine, pumiliotossine e decidrochinoline, composti in grado di alterare importanti proteine cellulari.
Serpenti che sfidano la morte

Delle 10 serpenti studiati, sei hanno rifiutato le prede velenose. Gli altri quattro hanno scelto di nutrirsi, ma prima di farlo hanno trascinato le rane sul terreno, in quello che sembra un tentativo di ridurre la concentrazione di tossine. Il team scientifico ha osservato questa procedura, che potrebbe essere una strategia per limitare il rischio di ingerire sostanze tossiche.
Tre serpenti sono sopravvissuti dopo l’ingestione, il che indica che dispongono di meccanismi metabolici in grado di elaborare o neutralizzare almeno parte delle tossine.
Secondo la biologa evoluzionista Rebecca Tarvin dell’Università della California a Berkeley, che ha supervisionato la ricerca, questi casi illustrano come le tossine possano plasmare l’evoluzione. “Solo pochi milligrammi di un singolo composto possono cambiare tutte le interazioni di un ecosistema”, ha affermato.
Meccanismi di difesa invisibili
I meccanismi per sviluppare veleno o immunità alle sostanze nocive differiscono tra le specie. Alcuni animali, come i rospi bufoni, producono le proprie tossine, glicosidi cardiaci che influenzano la pompa sodio-potassio, fondamentale per la funzione cellulare, mentre altri, come il pesce palla, ospitano batteri che producono composti mortali come la tetrodotossina.
Alcune specie acquisiscono le tossine attraverso la dieta. Le rane velenose ottengono composti letali ingerendo determinati insetti e acari. Nel corso del tempo, molte specie hanno adattato la loro fisiologia e generato varianti di proteine, come la pompa sodio-potassio, per impedire alle tossine di esercitare i loro effetti.
Tuttavia, questi cambiamenti possono avere delle conseguenze. La biologa molecolare Susanne Dobler, dell’Università di Amburgo, ha spiegato che più la pompa sodio-potassio è resistente ai glicosidi, minore è la sua efficienza, soprattutto nelle cellule nervose, dove la sua funzione è fondamentale.
Nelle ricerche sulla cimice dell’asclepia, Dobler ha osservato che questo insetto compensa con versioni alternative della proteina e tramite trasportatori ABCB, incaricati di espellere i composti dannosi dalle cellule.
Il ruolo del fegato e del sangue nella resistenza

Il team di Tarvin ha identificato che il fegato dei serpenti terrestri reali svolge un ruolo essenziale nella neutralizzazione delle tossine. Test su colture cellulari hanno rivelato che questo organo contiene enzimi in grado di trasformare i veleni in composti innocui e proteine che si legano alle tossine per impedire loro di raggiungere i loro obiettivi.
Un meccanismo simile è stato documentato nelle scoiattoli terrestri della California. Le loro proteine del sangue bloccano le tossine del veleno dei serpenti a sonagli.
Il biologo evoluzionista Matthew Holding, dell’Università del Michigan, ha verificato che la composizione dell’antidoto naturale degli scoiattoli varia a seconda dei serpenti della regione, dimostrando la coevoluzione tra predatore e preda.
Queste difese, tuttavia, hanno dei limiti. Anche i serpenti a sonagli possono morire per dosi sufficientemente elevate del proprio veleno, il che rivela la sottile linea di demarcazione tra resistenza e vulnerabilità.
Animali che usano il veleno a loro vantaggio
Alcune specie non solo sopravvivono alle tossine, ma le immagazzinano e le utilizzano come difesa. Lo scarabeo iridescente dell’apocino accumula glicosidi cardiaci delle piante ospiti sulla sua superficie. Quando viene disturbato, emette piccole gocce visibili sulle sue elitre, ha spiegato Dobler.
Questa forma di appropriazione chimica si riscontra anche nelle farfalle monarca, che raccolgono glicosidi dal cardamomo. Il biologo e genetista Noah Whiteman ha scoperto che uccelli come il picchio dalla testa nera hanno sviluppato una tolleranza alle tossine delle monarca e utilizzano questa capacità per nutrirsi di esse.
Whiteman ha spiegato il fenomeno: “È semplicemente incredibile il percorso di questa piccola molecola e la sua influenza sull’evoluzione”. Da una pianta di cardamomo in Ontario a una foresta montana a migliaia di chilometri di distanza, una sola tossina può trasformare le regole della sopravvivenza e ridefinire le relazioni tra le specie.